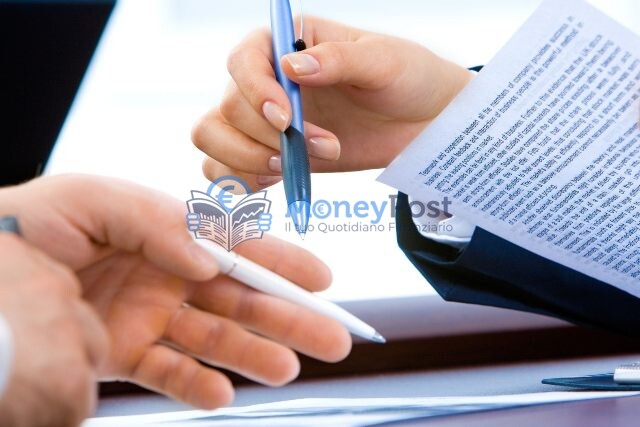Esistono diverse tipologie contrattuali, tra cui il contratto autonomo di garanzia. Si tratta di un contratto atipico per via delle sue peculiari condizioni, che lo portano a differenziarsi in maniera sottile ma decisiva con altri negozi giuridici, come la fideiussione. Nelle prossime righe cercheremo di fare chiarezza sulla sua natura e sul suo scopo.
Che cos’è il contratto autonomo di garanzia
Come dice il nome stesso, il contratto autonomo di garanzia è un contratto attraverso il quale il garante è obbligato a pagare una certa somma al beneficiario in modo immediato (“a prima richiesta”) in caso si verifichino determinati eventi, senza eccezioni.
L’unica eccezione e tutela di cui il garante può avvalersi è l’exceptio doli. Questa fattispecie si può venire a creare in caso di escussione della garanzia con dolo, mala fede, abuso manifesto e qualsiasi caso in cui il beneficiario agisca in modo intenzionale e consapevole per arrecare un danno al garante.
Spesso il garante in questione è rappresentato da istituti bancari o compagnie assicurative. Gli eventi, invece, sono generalmente costituiti da inadempimenti circa l’obbligazione del debitore principale o adempimenti inesatti o parziali.
Contratto autonomo di garanzia e fideiussione: differenze
In ambito giuridico, il contratto autonomo di garanzia è considerato un contratto atipico (art. 1322, comma 2, Codice Civile). Inoltre, è stato riconosciuto nell’ordinamento italiano principalmente grazie alla sentenza della Corte di Cassazione n. 7341 del 1987, nella quale si è fatta menzione della diffusione di questo tipo di contratto all’estero e della necessità, dal momento che viene ampiamente utilizzato anche in Italia, di regolamentarlo.
Al contrario di altri negozi giuridici, però, come per esempio la fideiussione, il contratto autonomo di garanzia è appunto autonomo. Di conseguenza, viene meno la garanzia con il vincolo dell’accessorietà e quindi la prestazione è esente da vincoli. L’unico vincolo è il rapporto obbligatorio che si crea tra garante e beneficiario.
Quindi, nel caso in cui il garante dovesse venire meno a quanto concordato, ovvero dovesse dimostrarsi inadempiente (o parzialmente o inesattamente adempiente), il beneficiario avrà il diritto di richiedere la somma di cui all’obbligazione del contratto a semplice richiesta. Questo aspetto ribadisce l’estraneità da vincoli che non sono quelli legati al contratto stesso, perciò stesso autonomo.
Di conseguenza, al contrario di quanto avviene per la fideiussione, nel contratto autonomo di garanzia il garante a prima richiesta ha l’obbligo di soddisfare il creditore a prescindere dalla ragione per cui si arrivi a questa conclusione. Ciò in quanto lo scopo del contratto autonomo di garanzia non è quello di adempiere a un debito, ma a indennizzare il beneficiario (creditore) tramite il versamento immediato della somma pattuita quale ristoro per la mancata o inesatta prestazione da parte del garante (debitore) (Corte di Cassazione, sez. I, sentenza n. 32402 del 2019).
Tipi di contratto
Il contratto autonomo di garanzia comprende tre diverse sottocategorie. Innanzitutto, troviamo una forma di contratto base, spesso impiegata nel caso di vendite, appalti e somministrazioni. In questa forma contrattuale tra l’ordinante e il beneficiario si crea il rapporto di valuta.
In secondo luogo, può crearsi con contratto di mandato di natura irrevocabile tra garante e debitore principale. Il garante dovrà stipulare un contratto di garanzia con il beneficiario del rapporto di provvista di base. In questo caso il garante può agire per conto del mandante anche se a nome proprio.
Infine, il contratto autonomo di garanzia può prendere la forma di contratto tra il garante e il beneficiario in cui il primo si obbliga verso il creditore al versamento di una somma pari alla prestazione dovuta dal debitore principale. Il versamento deve avvenire a prima richiesta (o immediatamente) e l’importo finale andrà maggiorato dei danni e delle spese.